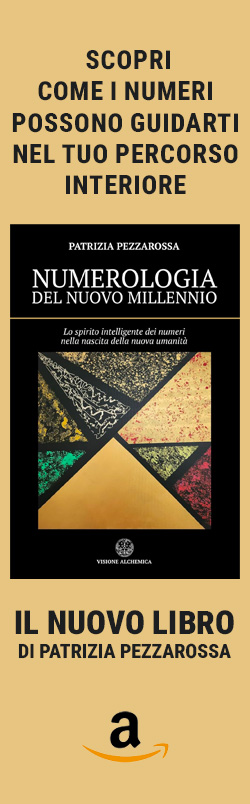Una parabola antica, custodita nei circoli sufi e tramandata da maestro a discepolo.
Non descrive solo il rapporto tra guida e ricercatore, ma l’incontro tra la nostra coscienza, l’Anfitrione e tutte le parti di noi che cercano ancora la loro casa.
Un insegnamento che agisce in silenzio, su più livelli, e che parla della pazienza, dell’accoglienza e della visione.
La parabola
Il maestro è come l’anfitrione nella sua casa.
I suoi ospiti sono coloro che cercano di studiare la Via e che non sono mai stati in una casa.
Essi hanno solo una vaga idea di ciò che può essere una casa, eppure la casa esiste.
Quando gli ospiti entrano e scoprono il salotto e chiedono:
«Che cos’è?»
viene loro risposto:
«È il luogo dove ci si siede.»
Allora si siedono sulle sedie, ma sono solo vagamente coscienti della funzione della sedia.
L’anfitrione li intrattiene, ma essi continuano a porre domande, talvolta irrilevanti.
Da buon padrone di casa non li biasima: per esempio quando vogliono sapere dove e quando mangeranno.
Non sanno che nessuno è solo e che, in quel preciso momento, altri stanno cucinando, e che esiste un’altra stanza dove si sederanno per mangiare.
Sono perplessi perché non possono vedere né il pasto né i preparativi; forse sono anche dubbiosi e talvolta a disagio.
Il buon anfitrione, che conosce i problemi degli ospiti, fa del suo meglio per metterli a loro agio, affinché siano pronti a gustare il cibo quando arriverà.
All’inizio, gli ospiti non sono in condizione di avvicinarsi al cibo.
Alcuni sono più svelti degli altri a capire e ad afferrare i rapporti tra i vari elementi della casa.
Sono loro che possono comunicare ciò che sanno agli amici più lenti.
In quel frangente, l’anfitrione dà a ogni ospite la risposta che corrisponde alla sua capacità di percepire l’unità e la funzione della casa.
Non è sufficiente che una casa esista, che sia pronta per ricevere ospiti e che l’anfitrione sia presente.
Qualcuno deve esercitare attivamente la funzione di anfitrione, affinché gli estranei — gli ospiti di cui egli si assume la responsabilità — possano abituarsi alla casa.
All’inizio, molti di loro non sono coscienti di essere ospiti, o non comprendono ciò che significhi essere ospite: ciò che possono dare e ciò che possono ricevere da questa condizione.
L’ospite di esperienza — colui che ha studiato le case e il senso dell’ospitalità — a lungo andare si trova a suo agio.
È in grado di comprendere meglio tutto ciò che riguarda le case e i vari aspetti della vita al loro interno.
Finché è impegnato a capire cos’è una casa o a ricordare le regole dell’etichetta, la sua attenzione è troppo presa da questi fattori per riuscire a osservare, per esempio, la bellezza, il valore o la funzione dell’arredamento.
Note sulla tradizione
Si dice che questa venerata parabola debba funzionare su diversi piani.
Si riferisce all’ordinamento delle diverse funzioni della mente, che può permettere a una percezione superiore di svilupparsi.
La parabola è anche destinata a indicare — in forma semplice da ricordare — le necessità di un gruppo sufi:
l’interazione dei diversi individui, il modo in cui possono completarsi e sostenersi a vicenda.
I dervisci danno molta importanza alla necessità preliminare di un assestamento dei vari fattori interiori prima che l’individuo possa beneficiare del lavoro del gruppo.
È una delle storie sufi sulle quali esiste un “embargo”:
non può essere studiata da sola.
Ovunque lo studente la trovi, deve immediatamente leggere e meditare anche la storia successiva.
Non appare nei testi classici, ma la si può rintracciare nelle raccolte di annotazioni che i dervisci portano con sé e consultano nel quadro di un programma concertato di studi.
Questa versione proviene da un manoscritto che attribuisce il racconto al maestro Amir-Sayed Kulal Sokhari, morto nel 1371.